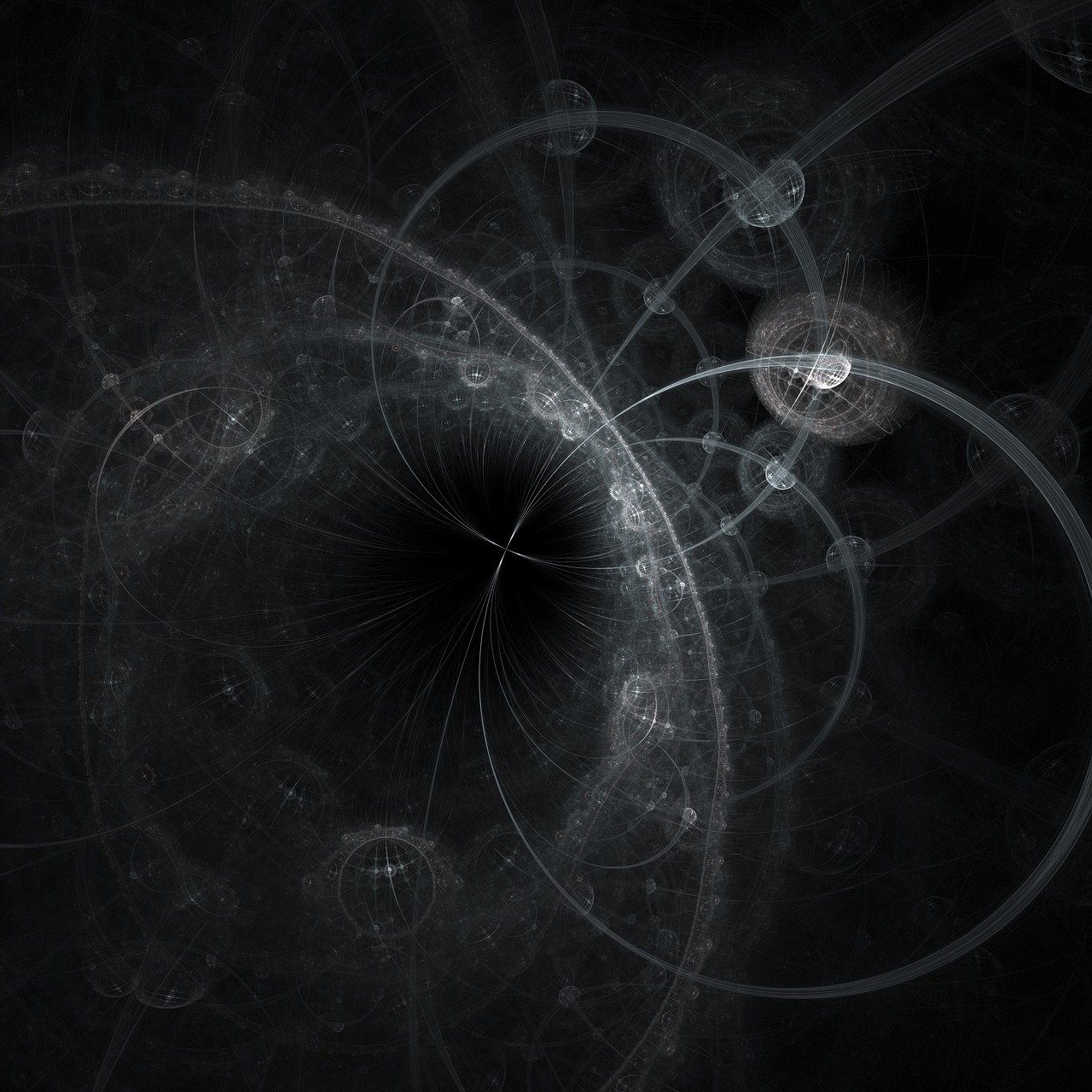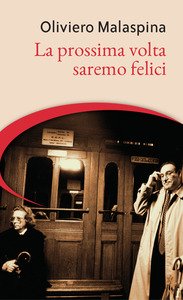A cura di Pasqualina Traccis
Lo spazio interviste di Eikasia oggi è dedicato al cantautore, scrittore e poeta Oliviero Malaspina. Pavese per nascita e cosmopolita per scelta di vita, Malaspina è un artista eclettico, originalissimo e pluripremiato che ha alle spalle anche una lunga e felice collaborazione con il grande Fabrizio De André e il talentuoso figlio Cristiano. La sua carriera musicale e letteraria è iniziata negli anni Ottanta dopo la laurea in Lettere. Negli anni ha pubblicato cinque album, due raccolte di racconti, due raccolte di poesie e alcuni saggi.
L’album Malaspina del 2014 e la raccolta di racconti La prossima volta saremo felici sono stati gli ultimi lavori più importanti.

A costo di sembrare poco originali, partiamo subito con una domanda sulla tua collaborazione con il grande Fabrizio De André. Quando è iniziata e come si è svolta?
La mia storia con Fabrizio inizia, non benissimo, al Teatro Smeraldo di Milano, nel 1992. Un’ora prima del concerto mi presento con la tesi di laurea di un amico, lui era come sempre molto teso e già proiettato verso il palco, dunque non ha dato molta importanza alla cosa, mi ha rivolto giusto due o tre domande di rito e si è tenuto l’elaborato.
Il rapporto vero è iniziato nel 1994, dopo la scrittura di “Notti di Genova” con Cristiano, il quale gli diede da leggere la mia raccolta di poesie “Vivere davanti alla luna fredda”. Mentre rientravo in auto da Milano nell’Oltrepo Pavese, mi arrivò una telefonata di Cristiano. Io pensai che ci fossero problemi con la canzone, ma lui mi disse: “ti passo un amico”. L’amico in questione era Fabrizio, il quale mi disse: “scrivi molto bene, devi essere una persona interessante e colta, mi piacerebbe conoscerti. Puoi venire dopodomani a casa mia per le 15: 30?” Ho sbandato con l’auto per l’emozione! Ci siamo visti dopo due notti insonni e sono bastati pochi minuti perché mi sembrasse di conoscerlo da sempre. Fin da bambino ascoltavo Faber tramite i dischi di mia madre e mio padre, la sua voce mi trasmetteva sempre una grande emozione anche se non potevo capirne il contenuto.
Dopo quell’incontro non ci siamo più lasciati. Mi aveva fatto un contratto triennale in esclusiva, voleva coinvolgermi nel progetto “Anime salve” dopo la separazione da Fossati e abbiamo iniziato a pensare ai “Notturni”.
Avrebbe inoltre dovuto produrre il mio disco “Benvenuti mostri”, cosa che purtroppo non avvenne, ma lavorò ad alcuni testi che conservo in una cassetta di sicurezza insieme ai “Notturni”. Avevamo in mente anche di scrivere un dizionario dell’ingiuria e un romanzo. Nel 1998 ho fatto da opener durante il suo ultimo tour e abbiamo lavorato ai Notturni fino alla sua morte, come si evince dal libro di Guido Harari “Fabrizio De André. Una goccia di splendore”.
Fabrizio era un rivoluzionario, più volte aveva innescato un cambiamento di paradigma nella storia della canzone d’autore italiana. La prima volta lo aveva fatto collaborando con un gruppo rock come la PFM, la seconda con l’album in dialetto genovese Crêuza de mä e infine intendeva farlo con i Notturni. In questo caso parliamo di quattro suite di 20 minuti ciascuna, con un cambio di scrittura rispetto al passato, niente rime baciate, solo assonanze, allitterazioni e rime al mezzo. Noi e i musicisti che avrebbero dovuto comporre le musiche avevamo tutti dei libri di riferimento. Purtroppo a causa della sua morte l’opera è rimasta incompiuta e inedita.
Tu eri molto più giovane di Faber, tuttavia mi pare di capire che avevate una bella intesa.
Sì, ci intendevamo alla perfezione, anche perché avevamo gli stessi gusti letterari. Antonio Lobo Antunes, per esempio, lo abbiamo scoperto insieme. Poi queste cose sono una questione di feeling che può nascere o meno tra due persone. Tra l’altro il nostro rapporto è nato nel periodo in cui si era disintossicato dall’alcool e dunque ho conosciuto un Fabrizio sereno, lucido e deciso, con molte idee e ben chiare.
Con lui avevo un rapporto molto libero e tranquillo, senza grandi discussioni. Mi rimproverò una sola volta, durante il tour, perché dopo la mia esibizione ringraziavo sempre il pubblico dicendo: “grazie, siete molto gentili”. Mi disse che quel “molto gentili” era di troppo. Mi fece notare che noi regalavamo poesia, bella musica ed emozioni al pubblico e dunque sarebbe stato sufficiente un grazie.
Racconto sempre anche l’episodio del gioco manageriale di calcio che mi aveva assorbito completamente e che mi faceva continuamente rimandare una telefonata di lavoro con lui. In un momento clou del gioco di simulazione, gli dissi: “non posso stare al telefono perché sto fallendo con l’Empoli e buttai giù la telefonata”. Si spaventò moltissimo, mi richiamò subito e con grande generosità si offrì di aiutarmi. Quando capì che si trattava solo di un gioco me ne disse di tutti i colori e mi obbligò a venderlo. Io e Faber ci siamo frequentati fino all’ultimo ricovero, dal momento che lui continuava a lavorare nonostante la malattia, senza mai perdere a sua ironia. La sua fragilità si esprimeva più che altro nel timore del giudizio del pubblico, ma per il resto era una roccia. Il mio ricordo di Fabrizio è, anche per questo, indelebile.
Poesia, letteratura e musica: gli antichi greci le riassumevano con il termine mousiké (“arti ispirate dalle Muse”), a voler stabilire un legame stretto tra loro. Questo concetto sembra particolarmente appropriato quando si ascolta o si legge Oliviero Malaspina. Cosa ne pensi?
Io credo che voler definire “poeti” cantautori come Fabrizio De André e come tanti altri sia un errore. La poesia è un’altra cosa, ha altri schemi, un’altra musicalità intrinseca e il processo di creazione è diverso. A meno che non si voglia dire che ci sono dei testi di Guccini, di Vecchioni o di Zenobi – solo per fare alcuni esempi – che sono più poetici ed emozionali di tanta poesia, cosiddetta sperimentale, che spesso lascia il tempo che trova.
In ogni caso io credo nel principio dei vasi comunicanti, nel senso che il background letterario personale finisce sempre per emergere e per intersecarsi con la struttura musicale che viene scritta prima o dopo il testo, a seconda dei casi. Il fatto che sia più difficile musicare un testo la dice lunga. Ci sono testi poetici che non sono musicabili in quanto hanno già una musicalità intrinseca. In caso contrario si farebbe incetta di Pavese o dei testi di tanti grandi poeti. Pertanto in genere si usa recitare i testi poetici con l’accompagnamento di un pianoforte. Io ho scritto due raccolte di poesie e ho l’onore di esser presente nell’Antologia del Festival Internazionale di Poesia di Genova.
Mi pare di capire – parafrasando Francesco Guccini – che a canzoni non si possa far poesia. Ma si possono fare rivoluzioni? Alcune delle tue canzoni lanciano messaggi forti e diretti. Sono provocazioni, l’espressione di uno stato d’animo o il tentativo di indurre una riflessione critica sul presente?
Credo che Francesco Guccini sia stato lungimirante e molto realista. A canzoni non si fa poesia e non si fanno rivoluzioni. Le canzoni forse possono rivoluzionare l’animo, il pensiero di una o più persone, ma se non si passa dall’idea all’azione non può fare nessuna rivoluzione. Il messaggio e l’emozione restano confinate nell’ambito soggettivo e non portano alcun cambiamento nel mondo esterno. Penso che sia stato lungimirante anche nel dire che i cantautori (termine discutibile anche questo) debbano “costruire su macerie” e mantenersi vivi, dato che non è più periodo per questo genere musicale che è stato letteralmente spazzato via in seguito ai cambiamenti economico-sociali e culturali degli ultimi decenni e tuttora in corso.
Ti senti un artista di nicchia?
Mi hanno fatto diventare di nicchia. La nicchia esiste per la comodità di chi non vuole o non riesce a investire su di te. Credo di avere un linguaggio abbastanza alto e non per tutti, ma di avere anche dei brani e delle melodie che possono arrivare a chiunque, in questo senso sono “deandreiano”. Se si prende un qualsiasi disco di Fabrizio, il quale ha un linguaggio alto e abbastanza difficile, si trovano sempre almeno due o tre brani che arrivano alla massa, con la giusta promozione ovviamente. Nei miei album, senza la giusta promozione, ci sono sempre due o tre brani che sono orecchiabili e linguisticamente accessibilissimi. Dell’album “Malaspina” posso citare “La strada”, cantata con Roberta di Lorenzo, “Vita ancora viva” o “Quasi tutti” che è una sorta di preghiera laica che ha un ritmo quasi dance.
Credi che la scelta – di mercato – di non investire sulla canzone d’autore e sulla musica di un certo livello sia legata in qualche modo al generale appiattimento culturale della società italiana degli ultimi decenni?
Di sicuro da decenni in Italia non si investe abbastanza in cultura. Ricordo il mio primo incontro con Mauro Pagani, che risale al 1980, il quale mi disse: “scrivi delle cose bellissime, peccato che questi siano gli anni Ottanta”. Poi sono arrivati gli anni Novanta e così via fino ad oggi. Non a caso le statistiche – che per una volta stanno in piedi – non ci collocano molto in alto a livello culturale in Europa e nel mondo. Basti pensare anche allo spazio che i media riservano al gossip o al post di questo o quel personaggio famoso rispetto a quello concesso all’arte, alla musica e alla letteratura. Non si dà abbastanza spazio alle nuove opere pubblicate in generale in ambito culturale.
Tuttavia la musica in TV e in generale sui media è presente e molto seguita dai giovani e dalle persone di tutte le fasce d’età…
Laddove in TV viene creato uno spazio per la musica si tratta di Sanremo e di competizioni ad esso legate o dei vari baracconi in cui i protagonisti non sono mai i cantanti. In generale in questi programmisi assiste allo scempio della musica. Chiunque è in grado di gridare per 50 secondi in un microfono, come succede nei Talent. Questi ragazzi hanno meno di un minuto per esibirsi e poi dietro spesso c’è il nulla. Si manda in onda la classica pre-intervista in cui si dice “io sono nato per fare questo”, ma poi bisogna vedere come realmente si gestisce la voce in un intero disco e soprattutto cosa c’è dentro. Spesso l’impatto con la realtà per coloro che partecipano a queste competizioni canore è devastante e la durata media della loro fama è molto breve.
Passando dalla musica alla scrittura, Proust diceva che “ogni lettore, quando legge, legge se stesso”. Pensi che si possa dire lo stesso di uno scrittore? Quanto ti raccontano le tue opere? A te stesso. Agli altri.
In linea di principio sono d’accordo con il maestro Proust. Tuttavia come Umberto Eco penso che un’opera letteraria sia sempre aperta, non solo per il lettore ma anche per lo scrittore, il quale ha sempre la tentazione di modificarli o di trasformarli proprio per la scoperta di un altro lato di sé che si aggiunge a ciò che è stato scritto e, in un certo senso, fissato in un momento precedente.
Nel 2014 è uscito il tuo ultimo album Malaspina. Nel 2017 è stata pubblicata la raccolta di racconti La prossima volta saremo felici. Possiamo dire che sono l’album e il libro degli ultimi?
Sicuramente sì, raccontano di persone che per scelta di vita o per destino conducono un’esistenza radicalmente diversa, sottraendosi al controllo di qualsiasi regime o potere che non può fare altro che disinteressarsene. Sono le prostitute, i clochard, i marchettari gay, gli zingari, tutte persone che rappresentano una forza reale, di carne e di sangue. Sono autentici rivoluzionari a mio avviso, il baluardo estremo dell’anarchia.
La tua scrittura, originale e poliedrica è caratterizzata da vere e proprie montagne russe di registri linguistici e da contrasti sintattici e semantici. Si tratta di una scelta stilistica o della convinzione che la dialettica degli opposti e il chiaroscuro sia l’unica possibile chiave interpretativa della realtà?
Io sono poco neorealista anche se poi finisco inevitabilmente per esserlo. In realtà a me interessano molto più i significanti dei significati, dopodiché spetta a chi legge o ascolta cogliere questo aspetto. Ho un sistema di scrittura personale e di questo sono felice, basato su opposizioni binarie, senz’altro, su chiaroscuri, anche musicalmente. Probabilmente ciò dipende anche dal fatto che ho studiato per dieci anni musica classica, da privatista, come chitarrista. Background di musica classica che si sentirà molto nel mio prossimo disco.
A proposito di progetti futuri, ci puoi dare qualche anticipazione?
Probabilmente per il Salone del libro di Torino uscirà il libro “Parto”, inteso sia come nascita che come addio, in cui si può ritrovare anche la figura di Faber. Sono delle mie prose poetiche su tavole di Antonella Spalluto. A settembre, per l’editore Fallone di Taranto, uscirà un libro scritto a quattro mani con Giuseppe Cristaldi, intitolato “Subumani. Drammaturgia degli invissuti”. Nel frattempo mi sono dedicato ad alcune soundtrack per vari eventi culturali e per il regista Umberto Baccolo, il quale ha realizzato un lavoro sulle transizioni sessuali giovanili e un corto intitolato “Appena prima della fine del mondo” , in omaggio a Sciolè. Per Biagio Sgangarella Valvano ho scritto la canzone “Meglio d’inverno”, contenuta in un doppio album in cui canta Fabrizio De André. Si tratta di un pezzo parlato in cui Fabrizio capisce che non ce la farà. Infine sto lavorando a un disco, con una impostazione in stile Notturni e delle varianti di stampo classico, con pezzi più brevi, nel quale vorrei riprendere anche i brani scritti con Faber che non ho inserito in “Benvenuti mostri”, rivedendone le musiche. L’idea sarebbe anche quella di uscire con singolo, scritto con il musicista Salvatore Papotto, intitolato “Il miraggio”.
Per saperne di più sull’artista clicca qui
Per acquistare il suo ultimo libro clicca qui
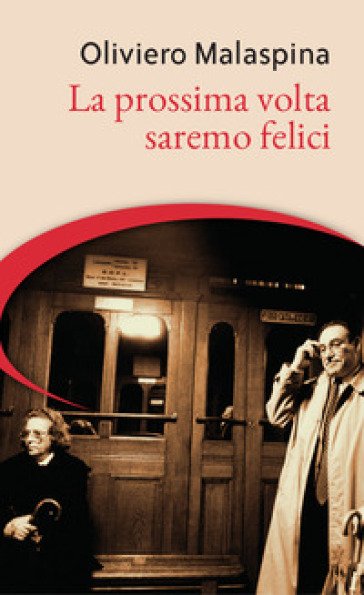
Per acquistare il suo ultimo album clicca qui